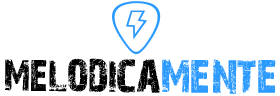Quando si parla di un caposaldo della musica come Bob Dylan, uno che ha venduto oltre 125 milioni di dischi nel mondo, credo che le presentazioni siano scontate e quindi le salterò. Vi dirà quindi che il Menestrello del folk ha deciso di far uscire una sua ennesima fatica discografica intitolata “Fallen Angels“, sia in cd che vinile, e che questa non contiene inediti: Mr. Tamburino ha infatti deciso di omaggiare 12 classici americani firmati da alcuni dei compositori più acclamati e influenti della storia della musica.
Questo nuovo disco, il 37esimo della sua carriera (un anno dopo l’acclamatissimo “Shadows in the night“) ci permette quindi di apprezzare non il Dylan compositore ma il Dylan interprete, arrangiatore e bandleader: anticipato da “Melancholy mood“, il nuovo lavoro di Dylan comprende canzoni tratte dal repertorio di compositori molto diversi tra loro, come Johnny Mercer, Harold Arlen, Sammy Cahn e Carolyn Leigh, e le ha incise ai Capitol Studios di Hollywood nel 2015 insieme alla sua band composta da da Charlie Sexton (chitarre), Stu Kimball (chitarre), Dean Parks (chitarre), Donnie Herron (steel guitar, viola), Tony Garnier (basso) e George Recile (batteria).
Questo nuovo album si inserisce in un solco tracciato qualche anno e qualche disco fa, quando Dylan ha deciso di cominciare una sorta di rilettura della musica americana filtrata dalla sua voce e dal suo talento musicale, ed è curioso notare come anche nel caso del disco precedente tutte le canzoni scelte da Dylan sono state anche eseguite da Frank Sinatra: Bob ha deciso quindi di farci da Cicerone in questo viaggio alla riscoperta della cultura musicale americana e ha deciso di farlo alla grande.

Il disco si apre con “Young at heart“, pezzo di Johnny Richards e Carolyn Leigh che Dylan suona e canta in una maniera pazzesca, catapultandoci per qualche secondo in un mondo e in un tempo che non esiste più: da questo mondo non usciremo mai più durante tutto l’ascolto del disco. Convinti di no? Ascoltate “Maybe you’ll be there” di Rube Bloom e Sammy Gallop e poi ditemi.
“Polka dots and moonbeams” di Jimmy Van Heusen e Johnny Burke si apre con una lunga introduzione strumentale tra il jazz e il folk sfiorando il country e Dylan si mostra completamente a suo agio in questo campo da grande musicista quale è: la magia continua con “All the way” di Van Heusen e Sammy Cah, brano di una dolcezza squisita, mentre l’interpretazione di “Skylark” di Hoagy Carmichael e Johnny Mercer strappa addirittura un sorriso per il suo fare un poco scanzonato rispetto al resto del disco.
Con “Nevertheless” di Harry Ruby e Bert Kalmar Bob Dylan continua con la sua narrazione e forse se si può porre un appunto su queste canzoni è che manca il tono un poco umbratile di “Shadows in the night”: in questo disco il folk singer ha volutamente cercato canzoni da adattare in maniera differente e più solare, come dimostrano “All or nothing at all” di Arthur Altman e Jack Lawrence e “On a little street in Singapore” di Peter DeRose e Billy Hil, forse la canzone più strana e particolare del disco che lascia un attimo interdetti: lo smarrimento dura però il tempo di una canzone e con “It Had to Be You” di Isham Jones e Gus Kahn si ritorna alla grande lungo la linea musicale tracciata dalle canzoni precedenti.
Il jazz sporco e criminale di “Melancholy mood” di Walter Schumann e Vick R. Knight Senior, brano scelto come primo singolo del disco, introduce la terzina finale del disco, ed anche qui una lunga parentesi musicale apre al cantato, in pieno territorio da standard: il ritmo di “That old black magic” di Harold Arlen e Johnny Mercer da vecchia locomotiva a vapore sembra quasi la musica dei film di Stan Laurel e Oliver Hardy mentre l’album si conclude con “Come rain or come shine” sempre di Arlen e Mercer, pezzo famosissimo cantato tra gli altri anche da Judy Garland, Ray Charles, Ella Fitzgerrald e Marlene Dietrich e qui cantato nella sua forma primigenia e naturale, degna chiusura di questo piccolo gioiello.
Quello che colpisce di più di “Fallen angels” non è tanto la musica quanto la voce di Bob Dylan: la rilettura di questi classici della musica americana ha trasformato il menestrello in uno storico delle sette note, un crooner a metà tra Leonard Cohen e Tom Waits. Tutto il disco ha un’atmosfera country di fondo molto elegante e di classe e Dylan si “veste” delle canzoni che canta giocando con la musica e con le parole ma usando tantissima delicatezza con l’una e con le altre. Il risultato finale è un disco al confine del capolavoro: la voce potrà essere non più limpida come un tempo, ma è perfetta per lo stile e per le canzoni scelte. Molte persone hanno detto (e continuano a dire) che Dylan non sa cantare: questo disco dimostra che hanno parzialmente ragione. Dylan non canta, fa una cosa differente: lui indossa le parole come abiti e li porta in giro con una naturalezza che solo l’esperienza sa dare. Un disco da salvare, da tenere sul comodino con cura e attenzione e da ascoltare quando il cuore fa male: tutto questo (e anche qualcos’altro) è “Fallen angels”.